☸ Arti Marziali ☯
di Dario Hermes Bellino
INTRODUZIONE
(Competizione - Difesa Personale - Culto del Qi)

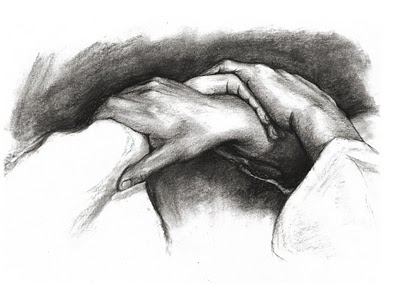

Spesso si fa una distinzione, soprattutto quì in Occidente, tra "sport da combattimento" ed "arti marziali", differenziando i due settori per ciò che a prima vista possano offrire: i primi, gare e traguardi agonistici; le seconde, un lavoro più lento, quasi mai competitivo, ed anche introspettivo. Ad una seconda analisi mi rendo conto che tale differenziazione può tuttavia non bastare affatto, e non tener conto di alcune variabili importanti, tali per cui risulta necessaria una nuova generale definizione, ed in particolare una classificazione più precisa, della Arti Marziali. In tal modo si può fare chiarezza nella mente di praticanti o aspiranti tali, e si può andare a ricercare radici e filosofie dimenticate di queste Arti. Se si sviscera la stessa parola, e ne si cerca l'etimologia, ciò che si scopre significare è "Arte della Guerra". Guerra intesa nelle sue varie salse. Per intenderci, la perfetta guerra alla "Sun Tzu" in cui "vittoria" sta per "cessazione del conflitto" preferibilmente senza spargimenti di sangue, quella alla "300 spartani" dei "pochi ma buoni", o ancora quella alla "inglese seicentesca" maniera in cui la quantità pareva valer più della qualità. Parallelamente a queste tre tipologie di guerra, la difesa personale tipica dell'aikido, i movimenti economici ed efficaci del wing chun, ed il metodo maggiormente da "incasso" della boxe occidentale. Arte della Guerra, pertanto, nelle varie accezioni che "guerra" e "vittoria" possano assumere. In tal modo si copre un maggiore spettro di tecniche e filosofie del "corpo a corpo", dalle arti marziali interne a quelle esterne, dalle morbide alle dure, da quelle maggiormente tecniche a quelle in cui il punto chiave è la stazza e la forza. Pertanto definirei l'Arte Marziale come un'Arte basata sull'apprendimento e ricodificazione di moduli e filosofie per l'iterazione con l'ambiente e le persone circostanti, ove vi sia l'idea o il compimento di un'aggressione od una sopraffazione. Infatti, nel linguaggio comune, le parole "marziale", "guerra", "vittoria", sono imprescindibilmente legate ad un qualcosa che abbia a che fare con un'aggressione, propria o altrui. Pertanto, mi sembra doveroso e logico settorializzare queste arti in base a nuove quanto elementari variabili:
➀ Arti Marziali in cui vi siano due aggressori che competono, e che quindi banalmente chiamerei "da competizione"; la vittoria è la supremazia, il mezzo l'abbattimento. ➁ Arti Marziali in cui vi sia un aggressore ed un aggredito, "da difesa personale"; la vittoria è la cessazione del conflitto, il mezzo la sopravvivenza. ➂ Arti Marziali basate sulla "manipolazione del Qi" proprio od altrui; il fine è la prevenzione, la cura, o la distruzione.
Queste tre tipologie, se in origine erano spesso intrecciate tra loro, nel XX secolo si sono sempre più scisse, finendo spesso con l'essere logorate e scarnate della propria essenza. Così il TaiChi da essere una delle arti marziali più micidiali e letali mai pensate, ha finito col trasformarsi in una ginnastica "new age", il Karate-do di Okinawa si è sportivizzato fino a diventare una forma light-contact da gare, e così via. Segue dunque che:
"L'Arte Marziale è l'arte di apprendere e ricodificare moduli e filosofie per l'iterazione con le persone e l'ambiente circostanti, ove vi sia l'idea o il compimento d'una aggressione propria o altrui e prevede, giunti o meno, la competizione, la difesa personale, il culto del Qi. La loro più alta espressione si è ebbe dall'India all'Asia orientale nel periodo che va dal VI al IX sec d.C., con l'applicazione e l'evoluzione delle idee legate (influenti, appartenenti, derivanti) al Buddhismo Chàn".
30/05/2013 Dario Hermes Bellino
(N.B. (clicca quì per vedere la mappa) 'Asia orientale' comprende: Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan. Secondo diversi autori, come Jeffery Broughton in "The Bodhidharma Anthology", Bodhidharma sarebbe stato originario del Sud dell'India, e di lì si sarebbe spostato via mare in Sumatra (Indonesia), Malaysia e Thailandia, entrando poi attraverso il Vietnam in Cina, dove diede origine a Shaolin ed alla dottrina Chàn, da cui arti e filosofie marziali si sarebbero diffuse e plasmate in tutta l'Asia orientale a seconda del contesto culturale, sociale, religioso, marziale, presente in ogni paese)
La differenza sostanziale tra queste tre tipologie di Arti Marziali sta attualmente nella loro incomparabilità. Non si può dire "questa tipologia è meglio di quest'altra" dacché sono oggi, nella maggior parte dei casi, cose completamente differenti, mirate a fini diversi e con mezzi diversi.
Un praticante di Arti Marziali da competizione generalmente non ha propri molti concetti e moduli di difesa personale liberi dai regolamenti. Allena il botta e risposta, accettando forse più degli artisti marziali da difesa personale le provocazioni, e reagendo ad esse chiaramente con ciò che ha appreso in palestra, ma senza guantoni. Tutto ciò è il semplice e naturale risultato della fase di apprendimento: in palestra l'atleta in questione si allena a gareggiare, iniziando gli scontri con entrambe le parti in posizione di guardia, tale per cui vi sia un rapporto di "aggressore-aggressore". Caratterialmente, le sue risposte agli stimoli esterni avranno generalmente matrice competitiva, nell'accezione del gareggiare e voler sopravvalere a terzi. Il problema in questo tipo di allenamento, starà nella caratterizzazione di personalità tendenzialmente inquiete al di là dell'apparenza, alimentando sempre il bisogno di sentirsi più "forti" degli altri, ed avendo quindi sempre un sottile rapporto di "superiorità-inferiorità" verso rispettivamente coloro che in gara otterranno meno punteggi, e coloro che ne otterranno invece di maggiori. Esistono a mio parere due tipi fondamentali di competizione: quella naturale, e quella tipica dell'uomo moderno. Ciascuno possiede l'istinto alla prima, e l'inclinazione alla seconda tanto maggiore quanto più marcati siano stati gli eventi o gli usi nella sua vita che abbiano visto nell'abbattimento di terzi la propria costruzione. Usando una metafora, in natura l'obiettivo sarebbe cacciare bene per procurarsi molto cibo, non cacciare bene per essere più "bravo" del homo sapiens della porta accanto. Un atleta allenato alla competizione, al gareggiamento, risponderà ad un'aggressione si per difendersi, ma ancor più per far vedere a se stesso ed agli altri la sua "bravura". Ciò è inevitabile essendo nato e cresciuto "marzialmente" in un ambiente in cui si dia un punteggio a ciò che fai rispetto a qualcun altro. Reagendo con questo spirito, si ha più probabilità di essere "abbatuti psicologicamente", oltre che fisicamente, qualora l'aggressore sia più forte del difensore divenuto anch'egli aggressore; in secondo luogo, l'atleta abituato ad affondare coi guantoni per abbattere l'avversario potrebbe danneggiarlo seriamente incorrendo così in problemi di natura legale (già nelle competizioni dilettantistiche ed agonistiche di pugilato, coi guantoni, sono state registrate in circa 100 anni più di 500 morti sul ring o nell'arco di un giorno dall'incontro per emorragie cerebrali o altri effetti collaterali), od al contrario potrebbe non essere preparato a situazioni particolari di difesa personale (come da prese o da armi). Assai positivo è che, generalmente, la preparazione atletica d'un artista marziale competitivo è superiore a quella di un'artista marziale da difesa personale, essendo più incline del secondo alle idee di sport. E' si più facile vedere un ex pugile muscoloso protagonista in qualche mischia, come d'altronde è più usuale osservare vecchi maestri esili di arti tradizionali con la pipa alla bocca. Tra i migliori e completi artisti marziali da competizione, che calzi perfettamente le caratteristiche di gareggiatore, superbo provocatore, c'è Muhammad Ali.
Un praticante di Arti Marziali da difesa personale è invece circa tutto l'opposto. Sempre in base, come del resto per qualunque pratica, alla natura stessa dello stile ed agli insegnamenti del maestro all'allievo, vi sono a loro volta diversi modi di rispondere ad un'aggressione. Tutte le arti marziali da difesa personale hanno però in comune il rapporto che sta alla base dell'allenamento: quello di "aggressore-aggredito". A differenza delle arti marziali da competizione infatti, è facilmente osservabile come, in queste, vi sia la maggior parte delle tecniche che partono da una presa al collo, al polso, al bavero, o ancora vi sia uno studio sul come comportarsi difronte ad un pugno, un calcio, un'accoltellata e così via. Questo tipo di allenamento mira a creare personalità "bastanti a se stesse". Non c'è bisogno di gareggiare, perché una competizione reale porta inevitabilmente ad una serie di danni fisici, morali e legali, a sè stessi e ad altri. Pertanto, l'atteggiamento dell'artista marziale da difesa personale è generalmente quello di non rispondere alle provocazioni, dal momento che non ha bisogno del plauso di una vittoria o degli spettatori. Purchè non vi sia contatto fisico. Se l'aggressore dice "fatti sotto!", l'aggredito in questione lascia correre come se l'aggressore non esistesse, o semplicemente si allontana per non avere rogne. In realtà, dentro di se assume un "kamae", ovvero un atteggiamento pronto alla difesa da un'eventuale attacco. Solo quando partirà per davvero un pugno, uno spintone, una presa, a sè stessi o ad una persona accanto, vi sarà una risposta, e questa risposta mirerà a fermare l'attaccante nel modo più veloce possibile (anche eventualmente attraverso colpi che in un'arte marziale da competizione verrebbero definiti "proibiti"; anzi, spessissimo l'allenamento è proprio su questo tipo di colpi). L'aggressore sarà costretto in altre parole ad afferrare ad esempio il polso dell'aggredito che si allontana (ed è così che entra in gioco una leva alla jujutsu) o sarà costretto a lanciarvisi contro (in questo modo iniziano le simulazioni d'attacco nell'aikido). La "vittoria" significa quindi "cessazione del conflitto", non la supremazia o la gloria. Il pensiero è "sopravvivere", non "competere". Rimettere a posto gli equilibri, e non distruggere. Fermare e non abbattere. Pertanto ciò che si fa durante gli allenamenti, è simulare delle aggressioni a cui si risponde secondo moduli e concetti tipici della disciplina insegnata, successivamente ricodificabili, "personalizzabili" (nella Bujinkan ad esempio si parla di "henka"). Proprio in questa aderenza e successiva personalizzazione, è insita l'arte, come un pittore con le tecniche dei suoi insegnanti. Come accennato ad inizio paragrafo, esistono diverse vie per la cessazione del conflitto. Prendendo tre casi modello tra tutti, in ordine dal più "duro" al più "pacifico", il WingChun, il Taijutsu, l'Aikido. Guarda caso, nello stesso ordine anche richiedenti maggior tempo per essere appresi ed applicati. Generalmente le arti marziali da difesa personale insegnano quindi a sopravvivere, a difendersi, ed a liberarsi dallo spirito competitivo tipico dell'uomo moderno di cui già la società ed il sistema capitalistico sono pregni. Per questo, non sono quasi mai adatte ad un ring. Una buona metà delle arti marziali da difesa personale allena anche ad attaccare, certo (ad esempio, nella pratica del "Randori"). Ma non a competere, dacché l'obiettivo è proprio quello di allontanarsi, liberarsi, dal bisogno di sentirsi più forti o dalla frustrazione nel sentirsi più deboli, rispetto a terzi. Piuttosto, diventare sempre più determinati ed imperturbabili. Con una sola frase Jigoro Kano spiegava tutto questo: "Non è importante essere migliori di qualcun'altro, ma essere migliori di ieri". Tra i più grandi artisti marziali da difesa personale, che calzi perfettamente le caratteristiche del guerriero non competitivo, penso senza dubbio alla figura di Morihei Ueshiba.
Un praticante di Arti Marziali da culto del Qi è attualmente colui che crede fortemente nelle tradizioni più profonde delle arti marziali indiane e cinesi. Si tratta di tutte le arti come quelle Nèijiā (XingYiQuan, TaiChiQuan, Baguazhang) ovvero arti marziali cinesi "interne", ma si tratta anche dello ShaolinQuan, l'HungGar, e di qualunque antica arte che si fondesse con la Medicina Tradizionale Cinese e con il culto più profondo del Buddhismo Chàn o delle filosofie orbitantivi (taoismo, confucianesimo, shintoismo). Compresi i più attuali KiaiJutsu e Kyusho. Anticamente, queste Arti Marziali furono le più micidiali e letali mai pensate dall'uomo, praticate generalmente solo da poche persone. Solo negli ultimi decenni stanno prendendo piede in Occidente, e spessissimo se ne ignorano le origini, si è scettici sull'efficacia dietro i loro movimenti, ed in generale non se ne riesce a comprendere la natura. Tuttavia grazie a maestri che si sono recati direttamente nel cuore dell'oriente per apprenderle dai pochi vecchi conoscitori ancora esistenti, sempre più persone vi si stanno avvicinando, intuendone l'essenza. Le Arti Marziali da culto del Qi sono nate da filosofie di irrobustimento del proprio corpo attraverso la conoscenza della propria energia vitale, e da quì si sono evolute anche da un punto di vista marziale attraverso l'ideazione del sistema del DimMak. Tra le personalità occidentali più importanti nella sfera di queste Arti Marziali, ne cito una per tutte, Erle Montaigue, scomparso pochi anni fa.
01/06/2013 Dario Hermes Bellino
Fondamentale è sottolineare che, in origine, le tre tipologie erano spesso fortemente intrecciate tra loro. Anche oggi, esistono esempi di questo legame. Uno tipico è dato da Bruce Lee. La sua vita, i suoi studi, la sua personalità, nel bene e nel male sono sempre stati fonte di ispirazione per molti atleti ed artisti. C'è chi dice sia il più alto esponente della difesa personale senza schemi, chi invece sia il fondatore dell'MMA, e così via. A me piace pensare che sia una via di mezzo tra le prime due tipologie. Nei primi libri che scrisse parlava infatti della sua idea di difesa personale, assai vicina a quella che fu la sua arte marziale di base, il WingChun: movimenti veloci, economici, bersagli maggiormente vulnerabili colpiti badando all'efficacia, più che alla forma. Poi, gli innumerevoli gareggiamenti lungo tutta la costa ovest dell'america del nord. Se, a questo proposito, come fanno in molti, gli si da carattere meramente competitivo, a mio parere in parte si sbaglia. Prima che un combattente, Bruce Lee era un filosofo, e nei suoi studi, nella sua arte, cercava di far capire come fosse importante il concetto, e non la tecnica. Cosa che invece era stata fatta da parte degli americani, nel momento in cui importarono dal Giappone e da Okinawa soprattutto, le loro "arti marziali orientali" prese solo nel loro "aspetto scenico" e non nei loro contenuti. Sia per volere nudo e crudo dei maestri nipponici a non insegnare i segreti dei loro movimenti ai generali degli eserciti stranieri, sia per una estrema superficialità tipica del modo di pensare occidentale. Per questo motivo, Bruce Lee è stato tra i primi a mostrare all'occidente cosa fosse davvero il KungFu corpo a corpo fuso con la filosofia del Taoismo, ridimensionando incredibilmente la fama dei sedicenti maestri di arti marziali orientali, americani, che si arricchivano vendendo prodotti estremamente "scremati". Ancora, c'è da dire che lo stesso Bruce Lee si è evoluto assieme alla sua arte ed alle sue idee, e leggendo suoi libri come "il Tao del Dragone" non mi sento assolutamente di definirlo un artista marziale da competizione, seppure l'apparenza porterebbe inevitabilmente a questo. Sono inoltre convinto che se avesse conosciuto personalità come Takamatsu, Ueshiba, Montaigue e così via, avrebbe trovato in loro molti punti di incontro con quella che era la sua idea di arte marziale, e si sarebbe forse ricreduto anche su molte arti marziali cinesi, giapponesi ed okiwanensi. A mio personale parere non si può dire, come purtroppo molti fanno, di insegnare il Jeet Kune Do di Bruce Lee, tenendo conto solo d'una parte del suo bagaglio tecnico e senza far prima propri i principi del Tao che lo portarono alla creazione dello stesso "non stile". Come pure non si può a mio parere praticare il Ninjutsu senza prima penetrare nel Buddhismo Mikkyo, non nell'Aikido senza prima conoscere lo Shintoismo, e così via. Uno degli uomini che mantiene integro, vivo, reale il legame tra tutt'e tre le tipologie in Italia, è ad esempio Shi Heng Chan, il monaco Shaolin formatosi direttamente nella culla delle arti marziali, i cui insegnamenti si nota come si discostino enormemente da quelli della stragrande maggioranza degli istruttori di arti marziali, indipendentemente dalla tipologia a cui esse facciano parte. Come sottolinea anche Shi Heng Chan, soprattutto quì in occidente, il nostro carico esperenziale, il nostro bagalio culturale, ciò che ci hanno insegnato, è pregno del bisogno di competere, di possedere, di esser preda di paure, di perdere di vista le reali priorià. La gente spesso è coinvolta consapevolmente ma passivamente in uno stato di stress psico-fisico a cui non sa rispondere se non come gli è stato insegnato nel luogo in cui vive. La maggior parte dei casi, in modo nevrotico. Non a caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta che tra qualche anno la nevrosi patologica potrebbe diventare la seconda malattia invalidante al mondo dopo i problemi cardiovascolari. Ma anche semplicemente osservando ciò che siamo, i nostri errori, e quelli di chi ci circonda, capiamo che c'è qualcosa di profondamente corrosivo nella società in cui cresciamo. L'arte marziale, anche per questo, dev'essere un modo per uscire fuori dagli eccessi, dal bisogno di competere, dalle paure immaginarie. Sopravvivenza, incorruttibilità, lealtà, pace, armonia. Ciò è possibile solo se è presa nella sua completezza, non vedendola solo come un bagaglio tecnico di mosse da utilizzare in un combattimento, ma andando a ricercare le origini e le filosofie della stessa arte.
02/06/2013 Dario Hermes Bellino

